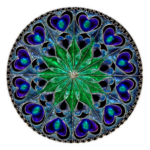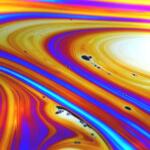Mi rendo conto che la diagnosi per me è un atto principalmente percettivo che solo successivamente assume l’aspetto della concettualizzazione. Mentre da ragazza credevo che si comprendesse la malattia in modalità esclusivamente cognitiva, attraverso la ricostruzione della storia, il collegamento tra i sintomi e l’interpretazione degli esami strumentali, ora mi accorgo che ciò che faccio ogni giorno è mettermi in una disposizione di appercezione sensoriale, quasi i miei sensi fossero canali nei quali fluisce il corpo del malato.
Questo non ha nulla a che fare con la pura sensibilità, cioè con l’elaborazione dei dati frutto della stimolazione dei miei recettori. E’ piuttosto un vestirmi del corpo del malato, intuendo in modo del tutto fisico ciò che esso sta comunicando in ordine al dolore, alle sensazioni, alle limitazioni.
I mie occhi toccano e le mie orecchie vedono in una sovrapposizione dei territori che non mi so spiegare.
Guardando percepisco il tono di un muscolo, quasi lo avessi tra le mani, la vibrazione regolare di un tremore, come fosse il mio braccio a oscillare. Ascoltando vedo l’aria scorrere vorticosa da una fessura, le gocce di muco vibrare sul piano glottico.
E’ un processo che non posso controllare, dotato di una immediatezza che non ha nulla a che fare con l’impulsività interpretativa.
L’interpretazione avviene ma in un secondo tempo, quando mi fermo a far dialogare le percezioni e a trovarne il senso.
Il momento diagnostico è l’approdo di un processo complesso nel quale è il mio corpo, prima della mia mente, a essere chiamato in causa in una sorta di rivestimento col corpo dell’altro.
Non è un approccio fantasioso, che trova immagini dove ode suoni. Si tratta, io credo, di un complesso fenomeno di embodiment empatico, che trae la propria origine dall’integrazione di reti neurali capaci di collegare territori diversi e lontani.
In questo senso la diagnosi non è un comprendere, cioè un prendere tutto ciò che è presente, riunendolo. La diagnosi è un capire, cioè un mettere dentro di sé ciò che sta arrivando dall’esterno.
Per questo forse visitare mi risulta tanto faticoso.
Per questo mi sembra insensato proporre protocolli di esercizi standardizzati per i vari quadri patologici a pazienti che sono inevitabilmente diversi, pur se affetti dallo stesso disturbo.
Occorre piuttosto favorire la consapevolezza corporea dei terapisti affinché, transitando da sé, arrivino a trovare ciò che a quel paziente, e spesso solo a quello, realmente è utile fare.