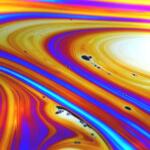Non impariamo a parlare per competenza logica né per desiderio di conoscenza. E’ piuttosto vero il contrario, impariamo a parlare perché abbiamo conosciuto e, parlando, iniziamo ad applicare i fondamenti logici del pensiero: le categorie.
L’uomo non viene portato come Adamo nel giardino dell’Eden a prendere visione di ogni animale e pianta, sino a quel punto a lui sconosciuti, e a dare a tutti un nome così da poterli dominare.
Noi nel mondo
Noi non siamo chiamati, come il Primo Uomo, a questo compito di controllo categoriale della realtà. Noi la realtà la “subiamo”.
Il nostro cammino verso il linguaggio non è rappresentabile da un procedere verso le cose ma piuttosto da un venire a noi delle cose stesse.
Proprio in quanto siamo toccati da esse, cioè le esperiamo in senso fisico, e ne siamo, per così dire “contaminati”, desideriamo dar loro un nome, cioè distinguerle, a nostro uso, dall’insieme vago della realtà lontana, per identificarci al centro di un mondo vicino, percepibile, esperibile, e quindi nominabile perché noto.
La percezione fonte del linguaggio
Ciò che permette la nascita del linguaggio è proprio la percezione, cioè la nostra capacità di congiungere la sensazione (ciò che sento con le mani, il gusto, l’olfatto, l’orecchio e vedo con gli occhi) a una affezione (cioè alla realtà degli affetti), così da dare alla “cosa” un senso, un senso per noi.
La fonte della capacità di parola per il bambino è il suo essere individuo estetico, cioè votato a sperimentare il mondo come sensazione e inevitabilmente chiamato a dare allo sperimentato un valore.
Ma l’esperire la realtà per mezzo di una percezione avvalorante dona soprattutto valore al soggetto che esperisce.
Se qualcosa mi tocca, si fa vedere, si fa udire ecco… io sono importante, io ho significato per essa (e quindi per il mondo).
E tutti noi non chiediamo altro che avere valore per qualcuno o qualcosa, in altre parole noi non chiediamo altro che di essere riconosciuti.
E’ così che mentre dalla capacità di percepire le cose arriviamo a dare loro valore, nominandole, da questo medesimo processo noi stessi usciamo valorizzati, perché degni di quella percezione.
La realtà mi viene incontro stimolando i miei sensi. Si fa presente al mio cuore prima ancora che alla mia mente. E’ così che senza comprendere e applicare categorie già so che essa mi ritiene degno della sua manifestazione. E tale manifestazione è buona.
Il linguaggio materno
La madre che parla al proprio bambino si presenta ai suoi sensi portatrice di stimolazioni che egli collega agli oggetti che essa nomina, alle parti del corpo di lui che accarezza, lava, copre, al cibo che offre.
Il volto della madre si rifrange nelle parole che in quel momento sta pronunciando. Ciò che essa porge al figlio affinché egli odori, tocchi, gusti conquista un nome proprio perché fonte di sensazioni nel dialogo con la madre.
Reciprocamente la madre accoglie ogni suono del bambino ripetendolo e restituendolo, come un uccello che mastichi nel proprio becco il cibo che il piccolo ancora non saprebbe utilizzare, per restituirlo, sminuzzato, ridotto alla sola forma sonora e, ma solo successivamente, di nuovo incatenato in parole.
Nominare la realtà non è frutto di un atto conoscitivo, nato dalla capacità cognitiva, ma è la deriva obbligata di un atto di amore.
Non imparo a parlare etichettando il mondo, organizzando immagini alle quali mi viene insegnato a collegare una forma sonora o un contenuto di pensiero. Imparo a parlare perché qualcuno mi ha valorizzato, presentandomi il mondo come fonte di percezioni buone e quel mondo è mio e mi interessa.
Imparo a parlare perché queste percezioni mi hanno spinto a un tentativo di nominazione e perché tale acerbo prodotto è stato accolto, rimasticato e rideposto nella mia bocca.