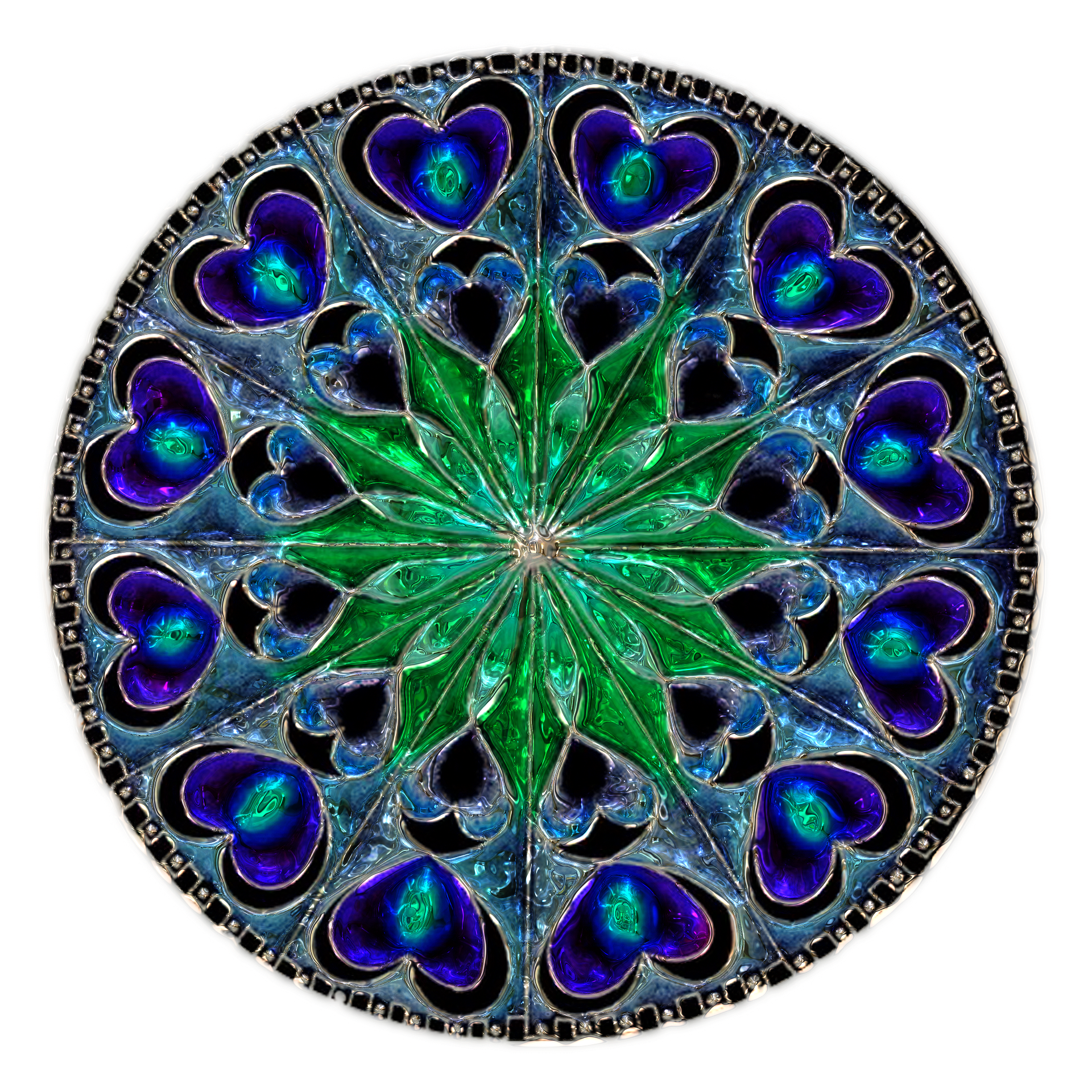Nessuno dei miei sensi lavora per così dire da solo.
La mia capacità di muovermi, di fare, di conoscere il mondo è il risultato della integrazione della loro attività.
La propriocezione è strettamente connessa alla vista e al vestibolo e quando uno dei tre non può lavorare appieno o è confuso dal sovraccarico sensoriale (una stanza buia, un giro in giostra ma anche una malattia neurologica) gli altri superlavorano, integrando e compensando.
Nel buio più completo, se devo camminare, cercare un oggetto nella borsetta, capire se vengo passivamente girata verso un lato, devo inevitabilmente far ricorso alla propriocezione per non sentirmi perduta.
Perfino la stereognosia, cioè la capacità di cogliere dimensioni e forma di un oggetto tenuto in mano, è opera sua.
La capacità della propriocezione di integrarsi con altri sensi non si limita a vestibolo e vista e non è confinata a tronco, testa e arti. Essa si estende anche a parte del canale alimentare e dell’apparato respiratorio ed è in grado di collaborare con tutti gli apparati sensoriali.
La possibilità di riconoscere un grano di pepe in un boccone, di individuarlo, separarlo e infine di sputarlo ad esempio è il risultato mirabile della collaborazione di propriocezione, tatto e gusto.
I miei piccoli pazienti che non masticano, che temono ogni novità nella dieta abituale, che si insalivano senza accorgersene hanno una bocca priva di un “sesto senso” che li guidi alla scoperta di ciò che in essa è contenuto, facendola percepire come un luogo sicuro, nel quale si può esplorare lo sconosciuto, apprezzarne la consistenza e infine il gusto.
Anche la capacità di parlare, di articolare i fonemi della lingua natale è dovuta a una raffinata propriocezione orale. Accedere al linguaggio parlato è il felice risultato della integrazione tra udito (ciò che sento), vista (ciò che vedo sul viso dell’altro mentre mi parla), propriocezione endorale e movimento.
Senza propriocezione non c’è movimento finalizzato
Senza propriocezione brancolerei nel buio di un corpo che sembrerebbe non appartenermi.
Dovrei far ricorso alla vista per ogni movimento volontario, controllando passo passo ogni azione. Perderei gli automatismi posturali. Imparando una lingua procederei per tentativi ed errori, fidandomi solo dell’udito.
Per avere una minima percezione di me dovrei espormi al vento, affidando al tatto e alla sensazione termica ogni informazione.
Questo senso dell’embodiment, del possedere e dello stare in un corpo, tanto prezioso e così poco valutato, è, come dice Oliver Sacks, l’ancora organica della identità corporea. E se, come insegna Freud, la base dell’Io è anzitutto l’Io corporeo, la propriocezione è fondamento della mia stessa identità.
Ecco allora che mi sembra chiaro perché molte tecniche di meditazione, che altro non sono che ricerca di un baricentro interno, fisico e psichico, partono proprio da percorsi autopercettivi finalizzati a ritrovare l’io corporeo, per arrivare a percepirsi come unità funzionale, integrata e integra.
Propriocezione e voce
A questo punto della riflessione è obbligatorio interrogarmi sulla voce.
La mia voce è l’espressione esterna del mio io interiore, emozioni e intenzioni comprese.
Ma potrei produrla in modo così congruente con ciò che sono se non mi sentissi completamente nel mio corpo?
Sicuramente no.
La mia voce uscirebbe incontrollata, monotona, troppo grave o troppo acuta, perché, vocalizzando, non avrei nessuna capacità di gestirla nel suo farsi, non potrei intervenire su quel delicato meccanismo che, mentre parlo, mi rassicura che colei che parla sono io, che ho nelle mani le redini di quella che altrimenti sarebbe una cavalla impazzita.
Mi interrogo ancora.
Questo essere nel mio corpo per il prodursi “della voce che parla di me” si risolve nel sentire le sensazioni generate dall’apparato fonatorio (dal mantice al vocal tract) e nel mettere in atto prassie congruenti? Basta cioè una propriocezione distrettuale?
La mia risposta è no.
La propriocezione del distretto non basta se non è integrata in un embodiment completo, se non percepisco l’unità di me, se non possiedo il mio corpo (possedere per abitare, non per controllare!) nella sua interezza.
Solo così , nella piena padronanza del mio sesto senso, posso sentire la mia voce non come un prodotto ma come una espressione di me, di quell’io corporeo, fondamento dell’io individuale psichico, che la mia voce porta nel mondo.
Quindi…..
A questo punto mi appare sorprendentemente congruente tutto il cammino che ho fatto per approdare alla cura della voce e le tessere di esperienze passate si ricompongono in una immagine unitaria, che da ragazza coglievo solo per frammenti.
La pratica dello yoga, con il suo dominio del corpo negli asana.
La conquista del qui e ora attraverso la propriocezione del mio corpo, del suo stare e muoversi nello spazio.
L’accanita ricerca di unità condotta attraverso le pratiche di meditazione mediate dalla gestione del soffio.
Lo stesso studio della medicina con il mio fissarmi testardo sulla fisiologia, che onoravo come grande madre della cura.
La diffidenza per tutto ciò che nella terapia della disfonia è puro esercizio, tecnicismo privo di sforzo consapevole di riappropriazione corporea
L’insistenza con i miei pazienti (così ben intesa e riprodotta dai miei allievi sui loro) sul “percepire il corpo” per gestire la voce, sull’abitare lo spazio per ben vocalizzare.
La certezza che la buona voce non è il “bel suono” ma la voce che, parlando di me, rimanda a una unità e armonia ritrovate.
Tutto questo mi appare ora giustificato.