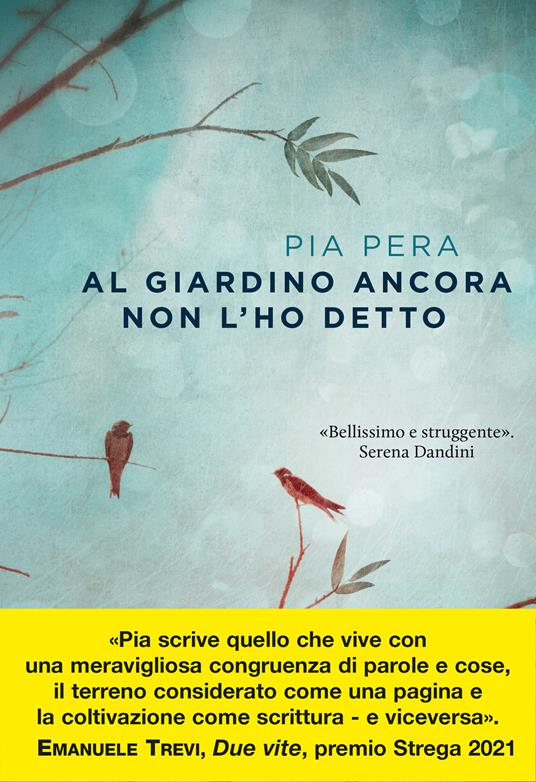“Prima il dovere, poi il piacere” è stato il mantra della mia formazione, dall’infanzia all’età adulta. Che venisse detto o solo implicitamente ricordato, mi è entrato nella mente tanto da determinare il mio comportamento. Questa regola, a metà tra l’etico e l’utilitaristico (ciò che fai, meritatelo; fai ciò che devi, che serve a te e agli altri) si è trasformata nel tempo da un dovere imposto a una morale interiorizzata e, cosa sulla quale non avevo mai riflettuto, una morale piacevole, perché quel “dovere”, proprio perché praticato quotidianamente ( si trattasse dello studio o del riordinare casa) è diventato per me esso stesso una forma di piacere. Fare i compiti non solo non mi pesava perché prodromo al gioco ma, proprio per la loro quotidiana frequentazione, quei compiti, dai riassunti, al greco, all’anatomia, hanno dispiegato davanti a me mondi che mai avrei attraversato se non avessi avuto la certezza di un luogo di paradiso al termine della strada, fosse la casa delle bambole, le prove della mia orchestrina rock o il cinema.
Era una educazione del dovere più che del dover essere. I genitori istruivano i figli al fare più che al pensare. Le famiglie venivano dalla guerra, la ricostruzione aveva segnato la loro giovinezza e il bisogno di riordinare un mondo distrutto dalle bombe faceva dimenticare che prima del fare esiste la domanda fondamentale del “chi sono” solo dopo aver risposto alla quale si può dar seguito al “perché agisco”.
Ma in quel dovere dello studio gemellato alla dedizione all’autorità scolastica, al quale ci obbligavano (malgrado il comportamento delle singole famiglie, in quel periodo focalizzato sull’arricchimento e la scalata sociale) abbiamo trovato i valori da seguire: l’uguaglianza, la parità tra i sessi, il rispetto dell’autonomia femminile, la valorizzazione della pace.
E’ così che la mia generazione è cresciuta, ed è così che abbiamo imparato a coltivare ideali per i quali compiere il nostro dovere (di femministe, di cittadine, di professioniste) era il prerequisito di qualsiasi godimento.
Nella lettura del libro di Twenge “Generation Me” e in “L’era del narcisismo” di Cesareo e Vaccarini, cerco ora una risposta al perché così poco la generazione che ci segue ci somigli e mi interrogo sulla possibilità che la pandemia possa portare a un cambiamento sociale.
I due testi sostengono un simile pensiero. Dagli anni 70 è iniziata secondo gli autori una progressiva valorizzazione dell’atteggiamento narcisista, secondo il quale il soddisfacimento dei desideri (quindi non l’adempimento dei doveri) è il primo obiettivo della persona. Ciò è dovuto a molteplici fattori, ne elenco alcuni, nati dalla lettura e dalla mia riflessione.
Primo tra tutti l’instaurarsi di un pensiero sociale non costruttivo né ricostruttivo ma favorente il solo consumo di beni, l’acquisto dei quali mantiene in vita l’economia dei paesi.
In secondo luogo la deresponsabilizzazione genitoriale nell’educazione dei figli dopo il periodo della scuola primaria, fatto questo che porta al maturarsi di una personalità plasmata dalle regole di mercato e non da valori condivisi dal gruppo famigliare o contrapposti a essi, in un atteggiamento comunque di valorizzazione di principi.
In terzo luogo, e questo è per me il più grave, nella riduzione progressiva operata dai governi degli investimenti per la scuola e la cultura (fruita e praticata), nella proposta parallela di luoghi di incontro deculturalizzati e omologanti, come sono i centri commerciali, unica piazza rimasta di socializzazione per i giovanissimi.
E’ in questa desolante prospettiva che interpreto il comportamento irresponsabile dei giovani che vivono a stretto contatto momenti sociali senza proteggersi dal contagio, esponendosi quindi al rischio di ammalarsi e di far ammalare chi è a loro vicino.
Non si stratta della sfida adolescenziale di chi conosce il rischio e lo ricerca nel percorso di autoaffermazione, non è l’equivalente della corsa in moto e della guida pericolosa (anche se l’invalidità e la morte possono essere comuni conclusioni). Non si tratta neppure del coraggio di chi sfida per ideale l’esistenza, non sono volontari arruolati in una guerra non loro. Si tratta, credo, delle conseguenze dell’atteggiamento narcisista di chi rimane attaccato all’idea di onnipotenza del lattante, per il quale la richiesta è sempre seguita dalla soddisfazione del bisogno, nella fiducia in un mondo buono che protegge e accudisce. Un atteggiamento che forse è dovuto alla mancanza di quel processo educativo (solo materno, al suo esordio) che, mentre qualcosa dà, qualcosa nega, costringendo il bambino a fare i conti con il limite, con la incontentabilità del desiderio.
E’ questo doveroso compito genitoriale, che porta alla vera autonomia, che chiarisce a chi sta crescendo che il desiderio va governato, la frustrazione accettata per conquistare davvero la propria libertà.