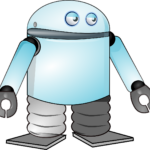Nonostante io sia ritenuta un’esperta di disprassia orale, sono un soggetto disprassico e la sua forma orale, quella cioè che interessa le abilità della bocca, è l’unica che non ho.
Se mi rompo mi aggiusterò
Sin da piccola sono incappata in incidenti che mi hanno provocato fratture e distorsioni e che vedono nell’ultimo di cui porto i segni, recentissimo, la loro trionfale apoteosi: sono volata dalle scale quindici giorni fa, fratturandomi un femore.
Nella mia lunga carriera di disprassica ho collezionato, vediamo un po’…. nove fratture. Ho iniziato a 4 anni con la rottura dell’omero, per proseguire poi con quella della tibia, del piede destro, due volte, del piede sinistro, due volte, del coccige, del dito anulare della mano sinistra, di tre coste, per arrivare a quest’ultima, del trocantere femorale. No, sono dieci.
E queste sono solo le volte in cui mi sono rotta. “Non sai cadere – mi dicevano – per questo ti fratturi”, non capendo che io non so neppure stare in piedi. Sono caduta entrando in chiesa il giorno del mio matrimonio, avevo otto centimetri di tacco, altezza per me vertiginosa. Sono rovinata giù dai gradini di un ponte veneziano alla nostra prima gita romantica, piangendo in modo così disperato da far fermare i passanti. Sono caduta a pelle di leopardo entrando per lavoro al Piccolo Teatro, al settimo mese di gravidanza del mio ultimo figlio, mentre il coccige l’ho rotto al nono mese del secondo, cadendo dalle scale buttando la pattumiera. Sono precipitata su una grata il giorno in cui sono andata a firmare il contratto con il mio nuovo editore e ho pensato: “se non mi tirano su, starò qui per sempre”.
Mi sono dimenticata di elencare tra gli incidenti la frattura della rotula destra, dovuta al mio tentativo di strappare un ramo di passiflora che spuntava da un giardino privato, per tentare un talea. E sono undici.
Essere derisi è la norma
Alcune delle mie cadute sono fonte ancora oggi di riso. La seconda frattura al piede sinistro me la sono fatta mentre avevo ingessato il destro. Ero al liceo. Immaginarmi con due gessi scatena perfino a me ilarità, come ripensare a quella volta qualche anno fa, in cui, stampellata per la frattura della rotula, sono precipitata a terra per strada procurandomi una distorsione dolorosissima alla caviglia sinistra, passando così l’estate con un pesante tutore per ginocchio da una parte e uno a valva dall’altra. E’ in quel periodo che ho letto, per alleviare la sofferenza, le 500 pagine del giallo “Uomini che odiano le donne”, mentre mio marito si dava all’opera omnia di Jane Austen.
Le coste le ho fratturate inciampando in un paracarro e cadendoci pesantemente sopra, così da conficcarmelo sotto l’ascella destra. Tornavo da una tempestosa riunione di genitori al liceo di uno dei ragazzi e stavo parlando da sola. Il dito, e il tendine che lo governa, li devo alla portiera di un autobus.
Sono disprassica o, se volete, goffa, imbranata, incapace. Non so saltellare su un piede solo, non so andare in bicicletta, figurarsi sui pattini! Non so fare un passo di danza, fare i gradini a due a due, camminare in montagna. Corro in modo penoso.
Un bambino disprassico si sente diverso e solo
Questa ultima frattura, unita alle competenze che ho maturato nel mio lavoro, mi ha fatto riflettere. Ho resistito al desiderio di buttarmela alle spalle, come una delle tante dalle quali, più o meno, mi sono ripresa e ho deciso di spiegare, guidata dalla condizione attuale, ai genitori dei miei piccoli pazienti come si sente una persona come me.
Lo sapete che un bambino disprassico si sente diverso? Uno che è una disgrazia avere in squadra in partita. Uno che non viene invitato mai a unirsi al gioco. Uno perennemente deriso dai compagni.
Lui teme ciò che per gli altri è divertimento (lo scivolo, l’altalena, il castello di arrampicata). Lui sa che non sarà mai adeguato, mai come gli altri.
Un bimbo disprassico guarda gli altri giocare, accontentandosi di dire “no grazie, non mi interessa” agli inviti che riceve. Un bimbo così sta in un angolo accontentandosi di osservare, perché il confronto con chi corre, salta, si arrampica è insostenibile. Un bimbo così non ama lo sport, anzi ne è terrorizzato. Vede l’ora di ginnastica come la prova suprema nella quale è certo di soccombere.
Un bimbo disprassico ha paura. Si sente continuamente oggetto di aspettative che non potrà soddisfare. A undici anni, figlia di un padre amante della montagna, urlavo, ferma sugli sci, “uccidimi ma non scio”. Invocazione non ascoltata sino a quando sono caduta rompendomi la tibia. Evento che ho festeggiato come la fine di un incubo.
Un bimbo disprassico quando si fa male si sente in colpa. La coscienza della propria inadeguatezza motoria è così viva che ogni caduta, ogni perdita di equilibrio, ogni frattura viene intesa come una offesa portata ai genitori, un fallimento imperdonabile.
Un bimbo disprassico spesso mangia troppo. E così facendo ingrassa, diventa sempre più goffo, sempre meno abile, ancora più diverso dai compagni e dai fratelli. Sono stata una bambina sovrappeso.
Se la disprassia coinvolge l’oralità, si vergogna della saliva che non sa contenere nella bocca, del tovagliolo sempre pronto sulle ginocchia, delle macchie di cibo che ha sul maglione. Se beve, sporca il bicchiere, lascia cadere nell’acqua residui di cibo, suscita disgusto.
Vorrei che questa mia riflessione rendesse consapevoli della pena che un bimbo così prova ogni giorno e che non è solo il senso di inadeguatezza per ogni compito motorio, la paura, l’isolamento. I bimbi disprassici soffrono perché continuamente sollecitati a fare ciò che non sanno fare, perché derisi e canzonati, perché poco sostenuti nella fatica quotidiana di fare con il proprio corpo ciò che per i coetanei è naturale, facile, spontaneo.